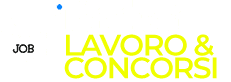Tra bizzarrie frutto dell’incuria e scherzi del destino, la nostra bellissima città di Palermo ne ha collezionate tante.
Emblematica è la storia di Santa Maria dello Spasimo, chiesa unica e suggestiva per via della sua architettura e di quella volta mancante che la apre al cielo. Ma, come dicevano i latini, nomen omen, nel nome c’è racchiuso il destino e il presagio: lo Spasimo, nome originario indicante la sofferenza della Madonna che vide andare al Calvario suo figlio Gesù, si è riversato sull’edificio e sulle opere in esso contenute.
Il primo, commissionato come chiesa per i benedettini olivetani dal 1509, passò al Senato palermitano già nel 1572, diventando teatro, magazzino e lazzaretto. Dal 1883 al 1985 addirittura ospedale, luogo di sofferenza per eccellenza; la tavola di Raffaello, nota come “Spasimo di Sicilia”, visse le più disparate vicende: scampata a un naufragio, fu posizionata nella chiesa per cui era stata commissionata fino, rimanendo a Palermo fino 1661, quando andò dritta in Spagna per volere del re Filippo IV, venne poi confiscata da Napoleone, per poi ritornare in Spagna al museo del Prado di Madrid dove si trova ancora adesso. Destino non diverso è toccato all’altare scolpito da Antonello Gagini e realizzato proprio per accompagnare il dipinto raffaellesco.
L’altare, dopo le operazioni di restauro, sarà a breve ricollocato nella cappella della chiesa, sotto una copia del dipinto, fortemente voluta da Vittorio Sgarbi e Bernardo Tortorici. Ma la storia del suo ritrovamento è molto complessa e intricata e me la faccio raccontare da Maria Antonietta Spadaro, architetto, storica dell’arte e docente, nonché artefice del ritrovamento di quest’opera d’arte. E non solo di questa. La professoressa Spadaro mi narra i fatti in modo dettagliato e appassionato come se leggesse un racconto d’avventura, che in fondo è stata la sua.
L’INTERVISTA
Professoressa Spadaro, ci racconti la storia di questa scoperta, di questo ritrovamento.
«La storia è complessa ed è il risultato di una serie di eventi che hanno poi trascinato anche me. Nel 1986, il professor Roberto Patricolo decise di fare un convegno sullo Spasimo e mi coinvolse. Dovevo occuparmi delle opere d’arte in esso contenute. A quel tempo non si poteva entrare: era un vero e proprio magazzino. I ladri avevano rubato tutto, compresa la fontana. Eravamo all’indomani della dismessa funzione di ospedale. Avevo due mesi di tempo. Mi concentrai sul quadro e ne studiai tutte le copie (parecchie) che si trovavano in tutta l’Isola. Ma l’altare era il vero mistero: c’era, ma, a un certo punto era scomparso. Lo conoscevo soltanto dalle fonti, come Gaspare Palermo o Antonino Mongitore. Poi… La nebbia. Fino a quando non avvenne l’evento fortunato: in un archivio della Sovrintendenza che si trovava in via dell’Incoronazione, trovai la fotografia. Potevo confrontarmi con un’immagine. Ricordo di avere provato la sensazione di toccare il cielo con un dito. Iniziai ad andare in giro forsennatamente per le chiese di Palermo, ma non trovai nulla. L’altare aveva subito vari spostamenti: era stato ospitato nella chiesa del Collegio dei Gesuiti, Santa Maria della Grotta, l’attuale androne della Biblioteca regionale. Lo sovrastava una scultura del Marabitti, raffigurante San Luigi. Era finito lì dopo essere stato nella chiesa di Santo Spirito, dove si erano trasferiti gli olivetani, ma poi anche nella chiesa di San Giorgio in Kemonia dal 1745. I Gesuiti lo avevano acquistato nel 1782. Nel 1888 confluì al Museo Nazionale dell’Olivella, così, nel momento in cui le collezioni si divisero (la sezione archeologica rimase in quello che oggi è il museo Salinas e quelle medievali e moderne arrivarono all’Abatellis), l’altare tornò ai Gesuiti, perché, probabilmente, vista la sua imponenza, venne ritenuto difficile un suo allestimento presso il museo. L’opera consta dell’altare, della cornice, di alte colonne e di decori. I Gesuiti lo mandarono a Bagheria, nella villa San Cataldo di loro proprietà fino a un certo tempo (poi passò alla Provincia). Lì lo trovai, tramite il gesuita Francesco Salvo e lo trovai smembrato. Sull’architrave che si trovava fuori, degli operai in pausa pranzo stavano seduti a mangiare. Mi premurai di riunire tutti i pezzi, cercando quelli mancanti nella villa. Parliamo degli anni ’80. Nel 1997 ritornò allo Spasimo e, solo da un paio di anni, sono cominciati i lavori di restauro».
Questa storia ha dell’incredibile. In seguito lei scoprì anche che la donna raffigurata in un ritratto contenuto a Palazzo delle Aquile fosse addirittura Charlotte di Borbone, nientemeno che la figlia del re di Francia Luigi XVI e di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena. In che modo è riuscita ad arrivare a questi ritrovamenti così rilevanti? Ci parli del suo metodo che l’ha resa celebre come “signora in giallo” dei beni culturali di Palermo.
«Il metodo è quello del detective. Sì, è vero, ho vissuto delle contingenze fortunate, ma non si può solo ringraziare la sorte: per perseguire un tale obiettivo ci vuole entusiasmo e soprattutto ostinazione. Le cose poi possono prendere una piega fortunata, è vero, ma non bisogna demordere né lasciare nulla al caso. Proprio come i detective».
Lo Spasimo è stato per lungo tempo lazzaretto, ospedale: è un luogo che ha conosciuto traversie e dolore, un dolore simbolo della nostra città martoriata negli anni da varie “pesti”. La sistemazione dell’altare sotto la copia del dipinto avverrà in un momento difficile, a causa della pandemia di Covid-19. Come legge tutti questi eventi?
«Proprio il 4 marzo, alla vigilia del lockdown, abbiamo fatto l’ultimo sopralluogo. I lavori di restauro sono cominciati nel settembre del 2018. Anche questo è stato uno ‘spasimo’. Ho scoperto l’altare decenni fa, eppure tornerà al suo posto solo tra qualche giorno. Ma il fatto che siamo in procinto di riuscirci è un bel segno, una piccola vittoria sulle difficoltà. E siamo nel 2020, esattamente nel cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello. Sì, è davvero una vittoria, se vogliamo leggerla così».
Professoressa, la ringrazio per la sua disponibilità, ma, prima di salutarla, vorrei farle un’ultima domanda: cosa consiglia ai giovani che si apprestano ad affrontare questa difficile professione, quella dello storico dell’Arte?
«Di amare ciò che fanno, di farsi guidare dalla passione. Mi è capitato di avere degli allievi che hanno poi proseguito su questa strada. A loro rendevo note le mie ricerche che andavano oltre il semplice insegnamento a scuola o all’università. Ebbene, oggi continuo a lavorare con alcuni di loro. Ci vuole, come dicevo, tanta passione ed entusiasmo. Bisogna divertirsi mentre si compie il proprio lavoro. Io l’ho sempre fatto».
Dovremmo gioire un po’ tutti – non solo gli addetti ai lavori – per questi eventi così importanti che uniscono il passato e il presente del nostro territorio, perché ogni opera che ritorna al suo posto è un tassello che va a comporre un mosaico più ampio di civiltà. La professoressa Spadaro ci ha inoltre mostrato quanto sia imprescindibile un principio in fondo semplice, quello del divertimento che deve accompagnare il lavoro di ricerca, lontano da un concetto parruccone e passatista della cultura che una rubrica come questa non potrebbe mai accettare. In barba a cinquecento anni di spasimi!